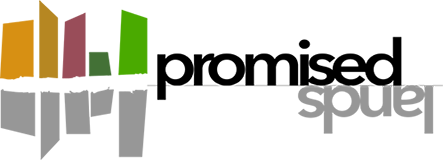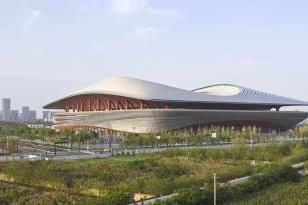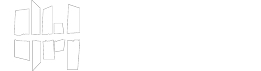Monumento vs Movimento (o forse no)?
Capita anche questo in tempi di mutamento dei paradigmi e di liquidità dei parametri di valutazione: che al Maxxi di Roma, praticamente in contemporanea, si possa visitare una esposizione dedicata a uno dei capolavori architettonici del dopoguerra milanese (attraverso i documenti di archivio, particolare non irrilevante nel nostro ragionamento) e un’altra pensata per celebrare il movimento come proprietà interna dell’architettura.

La prima (da 25.10 al 23.02.25) espone una ricchissima documentazione di archivio dedicata alla Torre Velasca (studio BBPR, Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers) che raccoglie davvero un tesoro unico dagli elaborati grafici, ai documenti che raccontano la storia dell’edificio, partendo dalle fasi iniziali alla lettera di incarico, dagli studi preliminari di torri mai nate all’inizio del cantiere. Ci sono quotidiani, riviste, sguardi di fotografi contemporanei in un percorso all’insegna del recupero della storia della struttura.
Struttura (recentemente ristrutturata) che fa parte dell’immaginario collettivo di tutti i milanesi. Un’esposizione quindi all’insegna della ricerca delle radici di un processo progettuale e costruttivo che ha portato i BBPR a scandagliare a fondo il rapporto tra stilemi storici e modernità, con una fortissima componente di radicamento sulla storia architettonica milanese. Quindi una mostra in cui l’architettura è sinonimo di evoluzione nella continuità e di univocità di forme e funzione.

E poi c’è la seconda esposizione, (da 25 ottobre al 16 marzo 2025) curata dallo studio newyorkese Diller Scofidio + Renfro, che scandaglia l’instabilità dell’architettura all’interno della società moderna, muovendosi su quattro principi di base: mobilità, adattabilità, operatività ed ecodinamismo.
La mobilità consente agli edifici di essere fisicamente trasferiti, sia che siano costretti a essere spostati per evitare la demolizione, sia che vengano trasportati altrove per scelta. L’adattabilità gli consente di essere riconfigurati e di assorbire i cambiamenti tecnologici o programmatici indotti dagli sviluppi economici o sociali.

L’operatività consente agli edifici di funzionare come macchine, sintonizzate sulle esigenze dei loro abitanti per servire scopi individuali o collettivi.
E infine, mentre la maggior parte degli edifici forma una chiusura ermetica contro gli elementi, l’ecodinamismo integra le tecnologie per creare interfacce flessibili tra un edificio e il suo ambiente circostante.


Quindi una mostra su un’architettura mobile, cangiante, mutevole per forma, funzioni e, anche, luogo in cui si esplica. Le due mostre sono un’ossimoro dunque, un inconciliabile dualismo tra “Diavolo e Acqua Santa”? Non sappiamo se al Maxxi abbiano studiato ad arte la sovrapposizione temporale delle due esposizioni, ma la domanda ci sembra lecita e intrigante.
Da vedere entrambe, una dopo l’altra, come un doppio shot di tequila da poi far decantare, per dare la propria risposta che sarà sempre personale e mai univoca (non potrebbe essere altrimenti).